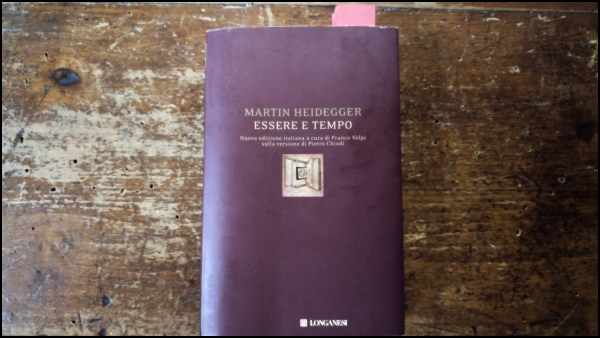Mi è occorso circa un mese per leggere e studiare “Essere e tempo” di Martin Heidegger, testo da cui mi ero ritratto qualche anno fa dopo lo sciagurato incontro con l’edizione di Mondadori, tuttavia ho optato per un suo secondo approccio quando, in quel di Torino, mi è capitata fra le mani la nuova edizione di Longanesi che si basa sulla storica traduzione di Pietro Chiodi.
Non che prima l’esistenzialismo o i concetti della filosofia di Heidegger mi fossero estranei, però ne lamentavo una visione d’insieme che fosse più organica. Un testo di questa portata richiede anzitutto una minima padronanza delle espressioni che sono state coniate all’uopo, talora ex novo da Heidegger stesso, nonché di quei termini ai quali egli dà accezioni diverse da quelle che sono invalse: ovviamente tutto ciò con lo scopo di superare i limiti linguistici.
“Gettatezza”, “intratemporalità”, “essere-nel-mondo”, “deizione”, “poter-essere”, “essere-per-la-morte” e il resto del vasto armamentario polisemantico che un’ardua ma efficace traduzione ha comunque reso accessibile anche a chi, come il sottoscritto, non conosce il tedesco. V’è un’intricata rete di rimandi che rende tutt’altro che facile l’assimilazione di quest’impianto filosofico, ma d’altronde non può essere altrimenti ed è come se questa stessa difficoltà ne fosse una parte costituente. Per quanto ostica, la lettura di “Essere e tempo” mi ha mostrato tutta la sua imponenza, però non si presta a quella dissezione aforistica che rende fruibili altri pensatori, ancorché al costo del loro pensiero. Pare che Nietzsche filosofasse con il martello, invece Heidegger, a mio avviso, lo fa con lo stesso trasporto con il quale un anatomopatologo redige un referto, ma proprio le analisi asettiche e lo stile didascalico del secondo mi catturano più delle evocazioni letterarie del primo. È pure vero che l’ontologia ha per sua natura un tratto che non agevola un certo tipo di digressioni, ma anch’essa può avere i suoi momenti di prosa.
Nel concetto di “essere-per-la-morte” ho rinvenuto una vaga affinità con un’idea che da tempo albergava in me, sebbene io vi sia giunto per altre vie e ne abbia raccolto solo una forma grezza. Di primo acchito il postulato della “deiezione” assomiglia a una delle tante critiche che taluni, a torto o a ragione, muovono puntualmente verso il cosiddetto volgo, però non è tale perché si trova su un piano diverso da quello in cui abitualmente scivola l’alterigia in materia di società. Uno dei cardini di “Essere e tempo” risiede nel concetto di Cura e nella sua immediata suddivisione tra prendersi-cura degli enti e l’aver-cura degli altri, anche se a me questa pare che sia una pietra angolare solo perché dev’esserlo per forza di cose: e per cose non intendo semplici-presenze. Ammesso che il punto di partenza sia l’Esserci nelle sue modalità di essere, ovvero autentica o inautentica a seconda che la chiamata della coscienza sia accolta o meno, uno dei punti di arrivo (seguendo l’ordine dell’esposizione) non può che essere la temporalità da cui deriva il concetto ordinario di tempo; è a tal proposito che verso la fine del libro ho letto un passaggio per me fondamentale: “Il prendersi cura quotidiano trova il tempo presso l’ente intramondano che incontra”.
In quanto ho appena scritto si staglia la tirannia del Si impersonale, però è improprio qualsiasi parallelismo con quel vago desiderio di affrancamento da uno stato non meglio precisato che si riscontra altrove, difatti Heidegger si astiene da giudizi di valore, o almeno io non ne ho colti.
Non si possono riassumere cinquecento pagine di una simile portata in poche righe dall’incerta successione, tuttavia ne bastano anche di meno per incensare un testo capitale nella filosofia del novecento e di cui ancor oggi si sente la forte eco. Non m’illudo certo che io abbia fatto del tutto mia quest’opera, per altro incompleta e gravata dal peso dei miei numerosi post-it, ma ne ho ricavato abbastanza per compiere un ulteriore balzo esistenzialistico verso Sartre.